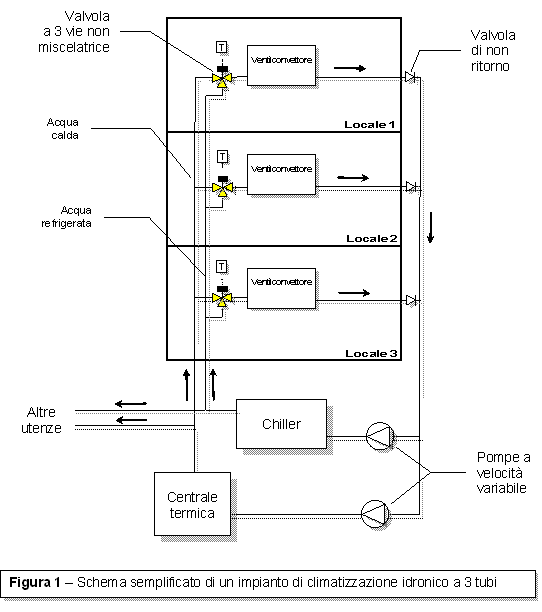TORNA ALLA PAGINA INIZIALE DEL
CENTRO STUDI GALILEO PER ULTERIORI INFORMAZIONI
 |
TORNA ALLA PAGINA INIZIALE DEL |
PRINCIPI DI BASE DEL
CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA
(95)
Impianti di climatizzazione
ad acqua a tre
tubi
Pierfrancesco
Fantoni
Introduzione
Come visto, gli impianti di climatizzazione idronici a due
tubi rappresentano la tipologia più semplice, dal punto di vista costruttivo,
per distribuire il caldo ed il freddo alle utenze. Inoltre il loro costo risulta
contenuto. A loro favore depone il fatto che consentono una regolazione autonoma
della temperatura in ogni ambiente dotato di termostato, con la possibilità,
anche, di escludere dal funzionamento alcuni ventilconvettori quando in alcune
stanze non è necessaria la climatizzazione. Tali impianti, però, non offrono
grande versatilità d’impiego soprattutto in quei casi in cui si devono
condizionare molti ambienti, dislocati secondo ubicazioni diverse (ad esempio
alcuni a nord ed altri a sud) e destinati ad uso diversi (ad esempio alcuni più
affollati di altri oppure contenenti fonti di calore diverse). Infine, non
bisogna scordarsi che spesso, nelle mezze stagioni, le esigenze termiche degli
utenti finali sono differenti: qualcuno vuole il caldo ed altri il fresco.
Con un impianto a due tubi non è possibile soddisfare
contemporaneamente esigenze contrastanti. Per tale ragione trovano applicazione
gli impianti a tre tubi, che permettono di superare le limitazioni proprie degli
impianti a due tubi. Essi si adattano particolarmente a quegli edifici in cui,
soprattutto nelle mezze stagioni, solo una parte di essi risulta essere esposta
al sole o perché esposta diversamente o a causa di ombre portate. In tale
situazione le temperature all’interno degli mbienti possono essere anche
sostanzialmente differenti, soprattutto nel caso in cui gli edifici sono dotati
di ampie vetrate che favoriscono i fenomeni di irraggiamento dall’esterno verso
l’interno.
Impianto a tre tubi
Rispetto all’impianto a due tubi, il terzo tubo viene posto sulla mandata e
serve a convogliare l’acqua calda o refrigerata al ventilconvettore. Con tale
espediente risulta possibile far funzionare le varie unità collegate in
parallelo sia in riscaldamento che in raffreddamento in maniera assolutamente
indipendente una dall’altra. Il vantaggio che se ne trae è indubbio: ora ogni
ambiente può essere climatizzato in maniera autonoma, essendo il circuito
specifico regolato unicamente dal termostato ambiente posto all’interno del
locale (vedi figura 1). Tale termostato ha il compito di comandare la valvola a
tre vie non miscelatrice
che permette il passaggio dell’acqua calda o
dell’acqua fredda nello scambiatore del ventilconvettore. Il ritorno dell’acqua
avviene mediante un solo tubo in cui fluisce sia l’acqua calda del circuito di
riscaldamento sia quella refrigerata del circuito di raffreddamento. In tale
modo, anche le condutture calde e fredde risultano essere in parallelo tra loro.
Normalmente sulla tubazione di ritorno, all’uscita di ogni
ventilconvettore, viene installata una valvola di non ritorno. Essa consente di
evitare la possibilità di avere flussi dell’acqua in senso inverso a quello
desiderato.
Con un impianto a tre tubi è possibile garantire un range di
temperature interne che va dai 20-21 °C a poco meno di 30 °C, sia per l’estate
che per l’inverno, a prescindere dalla condizione che gli ambienti climatizzati
siano colpiti dall’esterno direttamente dalla radiazione solare o che invece
siano posti in ombra.
Infine, mentre in un impianto a due tubi è possibile arrestare
manualmente il funzionamento dei ventilatori dei ventilconvettori, ottenendo
così una sensibile variazione dello scambio termico e conseguentemente della
temperatura dell’aria interna dell’ambiente, normalmente in un impianto a tre
tubi non viene reso possibile l’arresto manuale dei ventilatori, altrimenti si
otterrebbero perdite energetiche troppo elevate a causa della miscelazione
dell’acqua calda e fredda nella tubazione di ritorno. Infatti, con l’arresto dei
ventilatori si ha un brusco calo dello scambio termico tra acqua ed aria
ambiente, con limitato Δt sull’acqua che transita nella batteria del
ventilconvettore. Poiché tale acqua sulla tubazione di ritorno viene miscelata
con quella proveniente dagli altri ventilconvettori, può verificarsi che acqua
molto calda (che ha scambiato poco nel proprio ventilconvettore) vada a
mescolarsi con acqua molto fredda (che anch’essa ha scambiato molto poco). Tutto
ciò con una notevole perdita dal punto di vista energetico.
Una zonizzazione variabile
Dal punto di vista dell’utenza i vantaggi che tale tipologia
d’impianto offre sono evidenti. Ogni esigenza può essere soddisfatta, sia come
modalità di funzionamento (caldo/freddo), sia come regolazione della temperatura
ambiente.
In pratica si ottiene una zonizzazione spontanea dei vari
ambienti, che non risulta essere immutabile nel tempo ma variabile in quanto
decisa di volta in volta dagli utenti in base alle loro esigenze di comfort.
Tale zonizzazione non risulta essere dipendente dallo studio accurato di taluni
fattori quali l’esposizione dei locali, la loro dislocazione all’interno
dell’edificio e il loro utilizzo, come invece deve essere fatto nell’impianto a
due soli tubi.
Tuttavia questa caratteristica qualitativa positiva comporta
una maggiore complessità dell’impianto dal punto di vista della regolazione.
Infatti qui abbiamo il contemporaneo funzionamento della centrale termica e del
chiller per cui è indispensabile garantire la simultanea circolazione sia
dell’acqua calda che di quella refrigerata. Ulteriore elemento da considerare è
che la portata dei due circuiti non sempre deve essere quella massima, anzi. Se
in un circuito funziona con la massima portata significa che tutti i
ventilconvettori sono commutati sul medesimo funzionamento (o caldo o freddo),
il che significa che l’altro circuito deve essere disinserito. In generale,
quando funzionano entrambi i circuiti, significa che alcune unità funzionano in
raffrescamento mentre altre in riscaldamento per cui entrambe le portate dei
circuiti idraulici devono essere inferiori a quelle massime.
Questa esigenza impiantistica viene soddisfatta mediante
l’impiego di due pompe sui rispettivi circuiti del caldo e del freddo aventi la
caratteristica di poter garantire una portata variabile nel tempo in relazione
alle specifiche esigenze del momento.
Problematiche di regolazione
Risolto il problema di avere una portata variabile nei due
circuiti idraulici del caldo e del freddo, resta da chiarire quali dispositivi
di controllo impiegare per raggiungere tale scopo e quali accorgimenti adottare
per garantirne la funzionalità nel tempo.
Innanzitutto occorre impiegare un dispositivo in grado di
regolare la velocità delle pompe. Esso non può che funzionare sulla base della
necessità o meno di pompare all’occorrenza acqua nel circuito idraulico di
mandata. Allo scopo può essere utile un pressostato differenziale, in grado di
comandare le pompe in base alla differente pressione che rileva tra il circuito
di mandata dell’acqua e quello di ritorno. Così, grazie alla rilevazione del
differenziale di pressione rilevato è possibile aumentare o diminuire la portata
d’acqua in funzione delle richieste di caldo/freddo provenienti dai
ventilconvettori. Inoltre si evita una circolazione sovrabbondante di acqua
attraverso i ventilconvettori stessi quando non è necessaria.
Nel caso di funzionamento in raffrescamento, però, tale
soluzione comporta un ulteriore accorgimento da adottare. Infatti per bassi
carichi termici richiesti dalle utenze, il pressostato differenziale riduce la
velocità delle pompe e quindi il flusso di acqua all’interno del circuito
freddo. Di conseguenza il chiller deve soddisfare un basso carico termico: il
rischio è che la poca acqua in circolazione venga eccessivamente raffreddata e
possa anche congelare all’interno dello scambiatore. Infatti normalmente il
chiller lavora con temperature dell’acqua in ingresso di 10-12 °C mentre in
uscita di 6-7 °C. Una diminuzione del carico termico e della portata dell’acqua
può avere come conseguenza il congelamento dell’acqua refrigerata stessa, con
conseguenze immaginabili. Per evitare tale inconveniente è possibile pensare di
impiegare un idoneo by-pass che permette all’occorrenza di mantenere comunque
costante la portata di acqua all’interno dello scambiatore del chiller
indipendentemente dalla richiesta di freddo delle varie utenze.